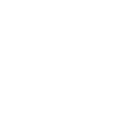Il paese, sviluppatosi nell’ultimo periodo dell'età medievale, fa parte della sub-regione del Mejlogu, situata nella parte settentrionale dell'altopiano di Campeda; ancora oggi, dopo un forte spopolamento, ha un’economia prevalentemente agro-pastorale.
La tessitura era un’attività femminile piuttosto rilevante in paese, incentrata da un lato verso i manufatti d’uso quotidiano e dall’altra verso una produzione assai specializzata che aveva la sua eccellenza negli arazzi e nelle grandi coperte nuziali. L’abate Vittorio Angius, compilatore delle voci relative alla Sardegna per il Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1833-56, così scriveva a proposito di Bonorva: «Le donne tessono tele e panni foresi di molta durata: però le più belle manifatture di tal genere sono le coperte da letto, ed i tappeti variamente figurati».
Negli anni Cinquanta del Novecento, quando l’attività della tessitura stava entrando in crisi anche a Bonorva, molto importante fu l’apporto dell’ISOLA e in particolare del suo direttore: il designer Eugenio Tavolara. Egli portò avanti una nuova tipologia di manufatti incentrata sull’elaborazione degli arazzi tradizionali, asciugati nei motivi decorativi e impostati sull’accordo di colori tenui e gradazioni di grigio.
L’apertura di un Centro Pilota ISOLA dedicato alla tessitura a Bonorva (ma anche nei vicini paesi di Osilo, Villanova Monteleone, Ittiri e Ploaghe), orientò decisamente la produzione verso i tessuti per l’arredamento, come gli arazzi (molto ricchi e decorati), a discapito della tradizionale manifattura dedicata al quotidiano (biancheria, teli ecc.), attualmente quasi del tutto scomparsa.
Oggi, anche dopo la chiusura dell’ISOLA, la Cooperativa Su Telalzu prosegue da un lato nella riproposizione dei modelli ideati da Eugenio Tavolara e Ubaldo Badas e dall’altra nella produzione di modelli derivati dalla tradizione; in particolare da segnalare i manufatti come i sottosella o le collane per cavallo, legati al settore equestre molto vivo in tutta la zona.
A Bonorva la produzione tessile era, ed è tutt’ora, impostata sul telaio orizzontale. Il telaio era piuttosto piccolo, come si evince anche dall’analisi dei manufatti di grandi dimensioni (coperte, nella variante linguistica locale fàunas), ottenuti dall’unione di più teli (normalmente tre).
Si realizzavano, oltre al corredo domestico, grandi coperte prevalentemente monocrome (bianche), oppure con decori simbolici – sempre più colorati a partire dai primi del Novecento quando si resero disponibili sul mercato locale le lanette tinte con l’anilina –, tutte con tecnica a ranu. Le coperte decorate vengono chiamate a beltighitta (dal nome del ferro utilizzato per tessere il disegno).
Sovraccoperte più preziose invece erano eseguite mediante la tecnica a mustra de agu, che consentiva una decorazione simile ad un fitto ricamo; questa lavorazione era fatta solo da tessitrici esperte e richiedeva molto tempo. Con la medesima tecnica si realizzavano anche gli arazzi.
Nelle coperte i decori erano suddivisi in uno spazio quadrangolare riservato al centro, sa mustra o su campu; quasi sempre strutturati in reti di grandi rombi o poligoni oppure in schemi “a cancellata”. I reticolati di losanghe, molto usati, riportano una croce fogliata o un astro, che richiama antiche monete; non a caso il particolare disegno è chiamato mustra de su sisinu (il sesino era una moneta corrente in Sardegna in età spagnola e sabauda recante solitamente su un verso una croce).
I disegni erano presenti anche nelle quattro balze, oros o istremos. Negli esempi ottocenteschi noti si riscontra raramente una cornice, di norma almeno due bande perimetrali opposte hanno decorazioni dissimili e non sono eccezionali i casi in cui tutte le quattro fasce esterne sono del tutto differenti. Questo si deve al fatto che le esecutrici non riuscivano a distribuire, nei tre o quattro teli che formavano l’intero manufatto, una fascia continua. I differenti tipi di balze, comunque, consentivano di sfruttare positivamente gli effetti di tali lacune tecniche, poiché si poteva orientare variamente il tessuto sulla faccia a vista del letto a baldacchino, simulando il possesso di più copriletto o scegliendo il lato più vistoso per le occasioni festive.
Le bisacce di gala presentavano una decorazione a scacchiera in bianco e nero, applicazioni di panno scarlatto e velluto di seta viola, cremisi o verde, profilate di cordoncini policromi, spezzavano la sobrietà di questi manufatti, attribuendogli un carattere festivo.
Con la tecnica a agu ed a ranu venivano tessute anche strisce multicolori per la realizzazione di sottosella festivi oppure, cucite in coppia, di collanas de caddu, destinate ad addobbare i cavalli nelle occasioni di festa; questa produzione è anche oggi molto presente.