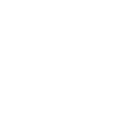Centro nella sub-regione del Goceano (650 m.), in provincia di Sassari, ha un’economia prevalentemente agropastorale, con diverse realtà attive del settore artigiano.
La tessitura a Nule, prevalentemente al telaio verticale, ha origini assai antiche e sino alla prima metà del Novecento era un’attività comunemente diffusa tra la popolazione femminile, che con questa produzione incrementava in maniera significativa l’economia familiare; erano le donne stesse che si incaricavano del commercio dei loro manufatti, spesso barattati in cambio di cerali, nei paesi vicini.
Dal testo ottocentesco redatto dall’abate Vittorio Angius, compilatore delle voci relative alla Sardegna per il Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1833-56, arriva la testimonianza che a Nule «Le donne si occupano a filare e tessere tele e pannilani per i bisogni della famiglia e per commercio con Ozieri e paesi vicini. Le più belle coperte che vendono i cillonari genovesi [recte gavoesi] sono da Nule».
Negli anni Cinquanta vengono organizzati dall’ENAPI (Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie) corsi di tessitura a cui partecipano molte giovani che si aprono all’apprendimento di nuove tecniche per la realizzazione di innovative tipologie di manufatto.
La svolta significativa per la produzione tessile di Nule avviene però negli anni Sessanta con l’istituzione, ad opera dell’ISOLA, della Casa del tappeto e l’intervento del designer Eugenio Tavolara. Un segno significativo del cambiamento si registra con la scomparsa del tradizionale puntu a traúccu (o puntu 'e s’intaccu) – che restituiva un diritto e rovescio –sostituito dalla "tessitura a stuoia", a doppio dritto. Anche il telaio verticale viene ora modificato per permettere di realizzare tappeti lunghi fino a otto e dieci metri.
Tavolara progetta dei manufatti in cui procede alla stilizzazione degli elementi decorativi di derivazione popolare, aggiornando, nel contempo, disegni e composizione con aggiunte di motivi di differente provenienza che creano un nuovo linguaggio segnico.
Nel 1982, l’ISOLA affida il Centro Pilota in comodato alla cooperativa di tessitrici "Madonna del Rimedio"; la crescente crisi nel mercato del tappeto porta negli anni Novanta a una drastica riduzione delle artigiane, con la conseguenza che, dal 1980, le tessitrici della "Casa del Tappeto" sono andate poco alla volta diminuendo, fino a raggiungere il numero attuale di 3-4 persone, seppure bisogna segnalare che alcune artigiane proseguono il loro lavoro al telaio in ambito domestico.
A Nule erano presenti il telaio orizzontale e quello verticale; i principali prodotti dalle tessitrici erano le bisacce (bértulas), i grandi sacchi per la raccolta di cereali (saccu 'e su laore), soprattutto orzo e frumento, le coperte da letto (fressadas) e l’orbace (furesi) per confezionare vestiti.
Per la maggior parte dei manufatti – bisacce, sacchi e coperte – si usava la lana naturale, nei due colori bianco e nero, a strisce alterne. Le coperte colorate, parte della dote, erano rare, e solo i più ricchi potevano permettersele.
Il motivo decorativo principale delle coperte, che costituisce un emblema della tessitura nulese (e anche dell’intera comunità), è quello cosiddetto "a fiamma" – dall'andamento romboidale del disegno, rassomigliante appunto ad una fiamma –, e rimanda al simbolismo del fuoco/focolare in tutti i suoi significati, anche se sembra essere l’evoluzione del segno a zig zag, che rappresenta il continuo scorrere dell’acqua. In alcuni casi il motivo della lingua di fuoco è ripetuto in continuità (pintura sighida), in altri è interrotto da variazioni: sos cálighes (i calici, derivati probabilmente da antiche raffigurazioni dell’ascia bipenne), sas rosittas antigas (le rose antiche), sos póddighes trottos (le dita storte), sas ambisúes (le sanguisughe), sos petteneddos (i piccoli pettini) e su fruninzu (florilegio), quest’ultimo una striscia orizzontale che contiene tutti i colori usati nella tessitura, come una specie di antologia. Le decorazioni formano cornici intorno a un campo monocromo attraversato solo dai motivi a sanguisuga.
La tecnica più antica per realizzare il disegno è quella a trame allacciate o agganciate, nella quale le trame colorate si intrecciano sul rovescio del tessuto tra le due catene di ordito che limitano il passaggio cromatico dei diversi blocchi di colore in senso longitudinale; questo importante segno della cultura tecnica locale è stato completamente abbandonato a partire dal 1950 con l’introduzione, nei laboratori tessili organizzati, di una tecnica che permette di ottenere dei veri manufatti a doppio diritto; la tecnica è a coda di rondine.