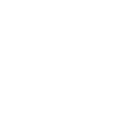Morgongiori è un pese dell'Alta Marmilla, in provincia di Oristano, con un'economia essenzialmente agropastorale.
La preziosa fonte ottocentesca costituita dagli scritti dell’abate Vittorio Angius, compilatore delle voci relative alla Sardegna per il Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1833-56, ci rivela che a Morgongiori erano attivi 200 telai su complessive 225 famiglie e che le donne tessevano in prevalenza lino coltivato in loco.
L'autore non aggiunge informazioni più dettagliate, facendo quindi presumere che la tessitura nel villaggio fosse rivolta soprattutto alla produzione di tele in lino di coltivazione locale, di buona qualità, in parte destinate alla vendita, come avveniva in tanti altri paesi sardi situati in pianura o in collina. Ai primi del Novecento il paese era già famoso per la produzione tessile, considerata tra le più interessanti della Sardegna.
Nel volume Arte Sarda, edito 1935 ma scritto diversi anni prima, gli autori Arata e Biasi, che per la prima volta presentano uno studio sui principali settori dell'artigianato sardo, ribadiscono che: ««Di un'armoniosa ed elegiaca bellezza sono appunto i tappeti che provengono da Morgongiori o da Santa Giusta; e sono quanto di più suggestivo e di più significativo esista nella produzione del genere. I tappeti di Morgongiori sono a cromatismi bassi: il rosso bruno con sfumature di turchino si frammischia col nero e con i gialli; qualche tocco d'oro e d'argento, ben distribuito tra i meandri, cosparge di un luccicante tremolio tutta la composizione decorativa. Gli sprazzi vivissimi e di gustoso effetto si alternano con tonalità scure, come se il colore passasse dalla gioia alla tristezza. Tra gli elementi decorativi che compendiano le varie figurazioni prese a prestito dalla fauna di cui sono ricchi questi tappeti, predomina il motivo a tralcio di vite, sempre disposto in senso orizzontale, il pino e il corallo stilizzati, i fiorami geometrizzanti e ricchi di frastagliature. Le varie decorazioni portano inseriti, di quando in quando, dei tondi entro cui una figura muliebre, munita di attributi e fiancheggiata da amorini, sembra che dia vita a tutto il pittoresco quadro. In molti esemplari di questa scuola, la composizione che copre tutta la parte centrale del tappeto è completata da due o più fregi entro cui sono disposti, in ritmiche teorie, cavalli e cavalieri, cervi dalle corna voluminose, aquile araldiche, uccelli e putti saltellanti».
Nei primi anni Sessanta anche a Morgongiori ad opera dei designer Eugenio Tavolara e Ubaldo Bads viene organizzato un corso di tessitura dell’ISOLA, seguito dalla nascita di alcuni laboratori.
Oggi l’attività ha subito un forte declino- Importante l'iniziativa portata avanti dal Comune, il “Museo vivente dell’arte tessile”; nello stabile si trovano infatti un laboratorio tessile e un’esposizione di manufatti. Nel laboratorio si trovano quattro telai tradizionali e uno spazio destinato alla vendita di quanto prodotto (arazzi, cuscini, tende, asciugamani, coperte ecc). Nel museo, visitabile su prenotazione, sono esposti molti interessanti manufatti del paese, quasi tutti di tipo festivo, come copricassa, bisacce, alcune coperte, ornamenti per animali e tovagliato.
A Morgongiori l'attività al telaio orizzontale era assai diffusa e improntata principalmente alla produzione di tessuti in lino, localmente coltivato, commerciati in tutta l'Isola.
Era altresì presente la lavorazione di tutti i manufatti necessari al fabbisogno quotidiano, anche se il paese era rinomato per la produzione di tessuti particolarmente lavorati, destinati alle occasioni festive, soprattutto i copricassa, impiegati per ravvivare i grandi cassoni nuziali, e le bisacce, quelle utilizzate per completare la bardatura a festa dei cavalli durante le sagre, come quella dedicata a sant'Isodoro, particolarmente sentita a Morgongiori.
I motivi decorativi presenti, assolutamente simili a quelli impiegati a Mogoro, solitamente inseriti in uno schema che procedeva per simmetrie, sono antropomorfi, zoomorfi, fitomorfi e araldici; la teoria di aquile e cervi alternati; il ramo di quercia carico di ghiande (su làndiri mannu); l'uccellino, rappresentato di profilo entro rombi; i pavoni e le pavoncelle ed altri uccelli; i motivi floreali e vegetali (uno dei più diffusi è la vite, in cui i grappoli d'uva si alternano ai pampini).