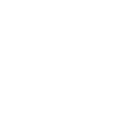Aggius (altitudine 514 m) è un piccolo centro della Gallura di tradizione agro-pastorale, oggi con diverse attività nel terziario e nell’artigianato industriale. Senza dubbio è il centro tessile più importante e rappresentativo di questa sub-regione isolana.
Aggius ha un’antica tradizione nell’ambito della tessitura, attestata sin da epoca preistorica dal ritrovamento nel territorio di una grande quantità di fusi, fusaiole e pesi da telaio, ma le prime notizie precise su questa attività risalgono ai primi dell’Ottocento con gli scritti dell’abate Vittorio Angius, compilatore delle voci relative alla Sardegna per il Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1833-56, che così scrive: «fanno tele molto stimate, e le vendono in molti dipartimenti del regno; lavorano, pure belle tovaglie, e alcune opere pajon molto superiori a’ mezzi che si hanno. Il forese di prima qualità è considerato come uno de’ migliori tessuti nazionali … Forse non si mandan fuor della provincia meno di 1000 pezze di lana, e altrettante di lino». Una svolta nella produzione tessile inizia nel settembre del 1927, con il Corso d’arte tessile popolare patrocinato dall’Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie (ENAPI), diretto e fortemente voluto dal prof. Giovanni Andrea Cannas. Egli ha infatti apportato importanti modifiche tecniche ai telai tradizionali, riadattandoli, e ha introdotto nel 1957 il telaio doppio (largo 210 cm) per una produzione più rapida.
A partire dal 1957, con la fondazione di ISOLA per volontà della Regione Sardegna, la tessitura artigianale si rinnova grazie alla collaborazione tra artigiane locali e due artisti-designer: Mauro Manca e Aldo Contini, che ampliano, soprattutto in senso contemporaneo, il repertorio dei modelli e dei decori. Così, accanto alla produzione usuale di tappeti, si fa spazio quella di grandi arazzi dal soggetto modernissimo e tappeti di notevoli dimensioni, legati nel decoro alle contemporanee e aggiornate istanze artistiche di Manca e Contini.
Sul finire degli anni Sessanta questa tipologia viene abbandonata in favore della riproposizione dei modelli della tradizione. Il Centro Pilota attivato dall’ISOLA nel 1999, dopo lo scioglimento dell’ente, è attualmente gestito dalla Cooperativa tessile prof. Cannas; lavora invece presso gli spazi del MEOC (Museo Etnografico Olivia Carta Cannas) un ristretto gruppo di tessitrici formatesi alla scuola diretta dal professore. La tessitura, attività di stretta pertinenza femminile, aveva ad Aggius (ma un po’ in tutta la Sardegna) un doppio ruolo all’interno della economia sussistenziale della famiglia, da un lato tramite essa si faceva fronte ai bisogni familiari inerenti il corredo domestico, personale e quello necessario al lavoro, dall’altro era merce di scambio e oggetto di un piccolo commercio che integrava le scarse entrate economiche.
Si tessevano al telaio orizzontale (di piccole dimensioni, circa 120 cm) lana e lino (di cui si è abbandonata la produzione negli anni Sessanta, sostituendolo con il cotone) localmente prodotti, lavorati e tinti con le essenze vegetali, reperibili nelle campagne del paese, con le quali si ottenevano colori particolarmente accesi. Nella tessitura della biancheria e delle camicie era impiegato il lino.
Il tessuto per tovagliati e asciugamani veniva realizzato con la tecnica a trame lanciate con la quale si ottenevano motivi di varia forma denominati scaccu a centesimi, a rosa, a mattoni, a spiga e a granu d’oldzu (a chicco d’orzo); esclusivamente per i tovagliati si utilizzava un elaborato disegno (chiamato lu scarramanu) a rombi concentrici, detti punghi, in numero variabile da due a sei, disposti a scacchiera. La lana veniva utilizzata per la tessitura piana in diagonale dell’orbace (fresi), per bisacce (béltuli), copricassa o tappeti, cuscini (capitali), cuscini da sella (capitaleddi) e coperte (sacchi di lettu o sacc’a cjai). Di questa ultima tipologia esistono due varianti: sacc’a cjai classico, caratterizzato da un motivo a scacchiera tessuto col ricorso a due spole di diversi colori; e il sacc’a cjai di stracci, che è la coperta più povera realizzata impiegando come trama strisce di tessuto di recupero. Questi tessuti sono prevalentemente realizzati con la tecnica a trama a vista.
I manufatti aggesi presentano prevalentemente motivi decorativi geometrici, ripetuti su fasce parallele; i disegni più antichi sono chiamati cjai e dati. Il primo, usato nel decoro delle coperte, consiste in un’alternanza di quadrati a due colori (uno chiaro e uno scuro) con effetto a scacchiera, che solitamente si sussegue a strisce monocrome. Più complesso risulta il disegno a dati: si tratta infatti di una serie di strisce orizzontali, separate fra loro da una fascia più sottile e di diverso colore chiamata pomu, contenenti vari soggetti come rombi di dimensioni e colori diversi oppure fiori o stelle.
La decorazione a rombi, punghi, è certo la più presente; questo motivo conserva nel nome la sua valenza apotropaica. Li punghi erano degli amuleti che, posti tra le fasce del neonato o tra gli abiti, avevano la funzione di tener lontano il malocchio; confezionati solo nei giorni di festa da donne prattiche, avevano la forma di un sacchetto di stoffa contenenti oggetti simbolici (reliquie, immagini di santi, incenso, ciuffi di capelli ecc.). Oltre al motivo geometrico si riscontrano anche elementi antropomorfi: la coppia di sposi (li spusini) e il ballo in cerchio (lu baddu tundu); e motivi zoomorfi in forma stilizzata, in particolare pavoni e uccelli (áia).