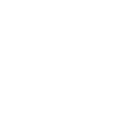Isili è situato nella sub-regione del Sarcidano (altitudine 523 m); paese tradizionalmente agricolo e pastorale con attività artigiane nel settore della tessitura e della lavorazione del rame, nel corso degli ultimi decenni, con l’espansione del settore terziario, ha modificato la sua struttura economico-sociale.
Nella prima metà dell’Ottocento, come si comprende dalla lettura delle parole dell’abate Vittorio Angius, compilatore delle voci relative alla Sardegna per il Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, 1833-56, il lavoro della tessitura ad Isili, non solo era particolarmente sviluppato e diffuso, ma aveva raggiunto risultati di eccellenza: «Le donne isilesi sono molto amanti della fatica e lavorano con intelligenza in circa 450 telai, coperte da letto con trame di lana di diversi colori, tappeti di tavola molto pregiati, bisaccie e il panno forese che dicono. I colori sono assai belli e formati con erbe indigene. Fanno pure coltri di lino con varie figure, cortine, pizzo assai largo, e tele molto riputate, e quando vanno alle fiere vincono nella concorrenza i tessuti degli altri paesi, e ottengono un prezzo maggiore».
A partire dai primi del Novecento avviene un importante mutamento nell’ambito della produzione tessile isilese: nel 1907 si apre la prima scuola tessile ad opera del cav. Giuseppe Piras Mocci, un impiegato dell'Ufficio del Registro originario di Bosa trasferitosi ad Isili.
Così la normale produzione domestica, imperniata su quanto necessario al vivere quotidiano e a un piccolo commercio, viene affiancata da quella di manufatti destinati a soddisfare la richiesta della nuova borghesia cittadina e dei primi turisti in cerca di prodotti dal carattere etnico.
Fatto del tutto nuovo, Piras Mocci, per facilitare le tessitrici nella riproduzione dei suoi originali accostamenti dei motivi della tradizione locale (al contempo ne introdusse di nuovi, probabilmente desunti dalle decorazioni dei filet di Bosa), riporta su carta quadrettata i disegni principali. Questa innovazione fa sì che, già a partire dai primi decenni del secolo scorso, Isili divenga un centro di produzione di manufatti che rispondono al gusto della nuova borghesia cittadina: tappeti, arazzi, bisacce, borsette, portafogli, cinture e bomboniere sostituiscono la produzione domestica.
Verso la fine degli anni Quaranta, con la morte del Piras Mocci, la Scuola del Tappeto Sardo cessa la sua attività.
Nel 1953 nasce il Gruppo Tessitrici Giuseppe Orrù, gestito dalle Suore Vincenziane; e proprio con la collaborazione di queste ultime l'INAPLI (Istituto Nazionale per l'Addestramento e il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria) organizzerà un vero e proprio corso professionale per tessitrici, seguito nel 1957 da un altro corso di formazione professionale voluto dll'ENAPI (Ente Nazionale Artigianato e Piccole Industrie).
Nel 1962 si fonda la cooperativa Tessitrici Madonna del Lavoro. A partire dal 1957, anno in cui sorge l’ISOLA (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano), il Gruppo Tessitrici Orrù inizia un'intensa collaborazione con l’ente nato, per atto costitutivo della Regione Sardegna, con lo scopo di guidare lo sviluppo del comparto artigiano.
I direttori artistici dell'ISOLA sono in quegli anni Eugenio Tavolara e Ubaldo Badas che introducono alcune varianti tecniche come l’utilizzo di telai più grandi, di circa 2 m di larghezza, che consentono il lavoro simultaneo di due tessitrici e l'esecuzione di manufatti di maggiore dimensione in minor tempo, e soprattutto propongono nuovi modelli e decori.
Un lungo intervento è stato successivamente portato avanti con le artigiane isilesi dal designer Piero Zedde, che ha inserito nella tessitura l’utilizzo di fili di rame, citando così la grande tradizione isilese nella lavorazione di questo metallo.
Il Gruppo Tessitrici G. Orrù ha cessato la sua attività nei primi anni Novanta; la Cooperativa tessile Madonna del Lavoro ha chiuso invece nel 1999.
La produzione più recente riguarda arazzi, tappeti, cuscini, borse, bomboniere ecc. Si segnala la presenta a Isili del Museo del Rame e del Tessuto.
A Isili la tessitura tradizionale era eseguita al telaio orizzontale (di piccole dimensioni rispetto agli attuali, infatti per la realizzazione di manufatti particolarmente ampi come le coperte si univano più teli), la materia prima impiegata era la lana, sia per l’ordito che per la trama, tinta con le essenze naturali.
Si produceva in ambito domestico quanto necessario a soddisfare le esigenze del quotidiano (biancheria, orbace per abbigliamento, teli per il pane ecc.) ma anche manufatti preziosi destinati a occasioni festive o rituali come i copricassa (cobericascia) e i copritavolo (coberibancu) o le coperta (crobetoxus po su letu).
Le tecniche di lavorazione principali erano: quella a pibionis (a grani o a riccioli), quella a schina de pisci, quella a mosta de pei e quella a unu in denti, la più diffusa, utilizzata per tessere la tela di fondo dei preziosi manufatti festivi lavorati a tenturai. Questa tecnica consiste nel creare uno o più disegni attraverso l'uso di due tavolette di legno sottile con la punta arrotondata (s'agu po tenturai e s'agu de palas).
La prima tavoletta permette il conteggio e la separazione dei fili che servono per formare il disegno da quelli dove si deve intravedere la tela; successivamente la tavoletta viene disposta trasversalmente, in modo da tenere sollevati i fili conteggiati, e avviene il passaggio manuale del filo che crea il disegno. S’agu de palas ha invece lo scopo di tenere sollevati gli stessi fili selezionati dal primo ago, in modo da predisporre l’ordito, una volta inserito uno stelo di giunco (oggi un filo di rafia), alla riproduzione facilitata e speculare dei motivi presenti nella prima metà del tessuto.
I motivi decorativi e le bordure erano riprodotti in apposite strisce di tessuto, denominate is cumentzus, con la funzione di facilitare la tessitrice nella riproduzione dei disegni. Questa campionatura, custodita gelosamente dalle donne, aveva una stretta circolazione all’interno dell’ambito della cerchia familiare. I motivi decorativi presenti sono numerosi, citiamo i più diffusi: Su broccáu – Il broccato; Sa pavonessa – La pavonessa; Su dindu – Il pavone; S’áquila o s’áchili – L’aquila; Is ocras – Le oche; Is puddas – Le galline; Sa pudda tremi tremi – La gallina tremolante; Sa pudda pillonada – La gallina con pulcini intorno; Su pilloni cun sa coa attrotoxiáda – L’uccello con la coda attorcigliata; Su pilloni de cáscia – L’uccello della cassapanca; Su pilloni fui fui Un uccello in movimento; Su pilloni de ada e ruxi – Un uccello con la coda incrociata; Is pillonis cúccur’a pari – Motivo geometrico con due uccelli; Is cèrebus a corrus longus – I cervi con le corna lunghe; Is cèrebus a pèis pinnigaus – I cervi con i piedi piegati; Is cerebixeddus – I cerbiatti; Is cuáddus dopius – I cavalli doppi; Is molenteddus – Gli asinelli; Su leoni – Il leone; Is lillus – I gigli; Is gravellus – I garofani; Is arángius – Le arance; Is isprighixeddus – Gli specchietti; Is isprighus mannus – Gli specchi grandi; Is arrosas incadenatzadas – Le rose incatenate; Is matas antigas – Gli alberi antichi; Su velludu – Il velluto; Is istellas – Le stelle; Sa mosta de aba – Motivo geometrico floreale; Is casteddus – I castelli; Is campanilis – I campanili; Su bastimentu o sa navi – La nave; Su dragu – Il drago; S’urrèi a cuáddu – Il re a cavallo; S’urrèi cun sa spada – Il re con la spada; Sa cassa manna – La caccia grossa (rappresenta una scena di caccia al cervo o al cinghiale); Sa cassa pittía – La caccia piccola; Santu Giorgiu – San Giorgio; Is ángelus – Gli angeli; Su ballu sardu – Il ballo sardo; Sa mosta e crésia – Rose ad otto petali all’interno di bordure geometrizzate.